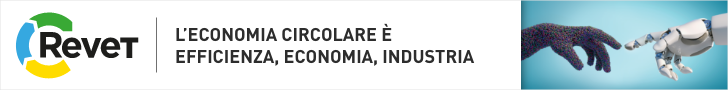Perché le bollette sono sempre più care, e cosa (non) possono fare le rinnovabili per abbassarle

L’elevato costo dell’energia è uno dei principali macigni che grava tanto sulle tasche delle famiglie, che si trovano a pagare bollette sempre più care, quanto sulle possibilità di sviluppo economico del Paese. La diffusione delle fonti rinnovabili è un elemento essenziale per fare un salto di qualità, ma nell’interregno verso la decarbonizzazione che stiamo vivendo non è sempre facile vederne i benefici, come pure gli aspetti ancora da correggere. Come si forma il costo in bolletta? La liberalizzazione del mercato ha inciso sul loro costo? Come funzionano i contratti a lungo termine? Come funzionerà l’Italia con 7 diversi prezzi zonali per l’elettricità? Di questo e molto altro abbiamo parlato con Andrea Alberizzi – docente a contratto per l’Università di Ferrara e ricercatore del centro di Ricerca sul sistema energetico (Rse) – e Luisa Loiacono, ricercatrice all'Università di Ferrara.
Intervista
Seguendo l’andamento del costo del gas, il prezzo di riferimento all’ingrosso dell’elettricità nella Borsa elettrica italiana (Pun) è salito da circa 60 €/MWh del febbraio 2021 a 210 €/MWh l’anno successivo, per poi tornare adesso attorno a 120 €/MWh. Perché dunque i costi delle bollette continuano a crescere, c’entra la fine del mercato tutelato?
«Innanzitutto, è importante chiarire in che modo il prezzo del gas influenza il prezzo dell’elettricità. In Italia la maggior parte dell’elettricità è scambiata per le varie fasce orarie della giornata in un mercato giornaliero (Mercato del giorno prima) in cui si forma il prezzo finale: il prezzo è dato dall’impianto più costoso che viene utilizzato in quel giorno per soddisfare la domanda ed è uguale per tutti i produttori. Ciò significa che, fatta 100 la domanda di energia, se anche 99 fossero coperti da impianti rinnovabili a basso costo, basterebbe che l’ultima unità fosse prodotta da un impianto a gas perché il prezzo dell’energia dipenda da quello del gas (il cosiddetto prezzo marginale). Si noti che nonostante circa il 75% dell’elettricità venga scambiata nel Mercato del giorno prima, una buona parte della restante parte è scambiata tramite contratti a lungo termine, e quindi la diminuzione del costo dell’energia ci mette parecchio tempo prima di riflettersi sulla bolletta».
Il costo della bolletta elettrica dipende solamente dal prezzo dell’elettricità?
«No: oltre al costo dell’energia, un costo variabile che dipende dalla quantità consumata, in bolletta ci sono altre tre componenti. I costi di commercializzazione e vendita, costi fissi, indipendenti dalle quantità consumate e stabiliti dai fornitori, gli oneri di sistema e la spesa per il trasporto e la distribuzione, stabiliti dall’autorità per l’energia (Arera), e gli oneri fiscali. Quindi i fornitori hanno spazio di manovra sul costo dell’energia e sui costi fissi, mentre non determinano gli oneri di sistema, la spesa per il trasporto e la distribuzione e gli oneri fiscali. Per comprendere cosa accade nelle nostre bollette bisogna quindi vedere cosa accade a tutte le componenti.
Per quanto riguarda gli oneri di sistema e gli oneri fiscali, ci sono stati, a partire dagli anni della pandemia, interventi che hanno ridotto la spesa complessiva che paghiamo in bolletta. Dal 2021 il governo ha azzerato gli oneri di sistema, re-introdotti poi ad aprile 2023. Inoltre, a partire da gennaio 2024 è stata annullata la riduzione dell’Iva sul gas naturale, che è adesso pari al 10% per gli usi civili (che da ottobre 2021 era stata ridotta al 5%). In parte quindi, la diminuzione dei prezzi dell'elettricità non ha fatto diminuire il totale della bolletta a causa della fine di questi interventi.
Guardando i soli dati del 2022 e 2023, dalle stime di Eurostat, si evince che a fronte di un prezzo dell’elettricità rispettivamente pari a 0,30 €/kWh e 0,13 €/kWh il costo medio pagato in bolletta per una famiglia (al netto degli oneri di sistema, degli oneri fiscali e della spesa per il trasporto) è rimasto invariato e pari a 0,24 €/kWh. Dalle prime stime emerge che anche per il 2024 e per il 2025, i prezzi delle bollette elettriche continueranno ad aumentare, soprattutto visto che il prezzo dell’elettricità a gennaio 2025 è aumentato del 40% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente (0,10 €/kWh nel 2024, e 0,14 €/kWh nel 2025)».
Quindi come mai i costi delle bollette non diminuiscono?
«È verosimile che a seguito del processo di liberalizzazione del mercato, i fornitori stiano attuando politiche collusive aumentando i costi, fissi o variabili, dell’energia. A questo aumento generale dei costi, si aggiunge il fatto che le bollette energetiche sono poco chiare e le offerte tutt’altro che limpide. All’interno delle bollette gli elementi sopra descritti sono tradotti in voci poco chiare, che non permettono all’utente medio di farne un’analisi esaustiva per capire quale tariffa sia più conveniente. Si pensi che, considerando un consumo medio annuo di 2700 kWh, al netto degli oneri di sistema, delle spese per il trasporto e la distribuzione e degli oneri fiscali, le offerte per i soli costi per l’energia e per i costi di commercializzazione e vendita possono variare da circa 300 euro a più di 1.000 euro all’anno».
Il nuovo “decreto bollette” approvato dal Governo stanzia circa 3 mld di euro e taglia i costi energetici per cittadini e imprese per 3 mesi; nel caso delle famiglie con Isee fino a 25mila euro, si parla di circa 200 euro di risparmio. Sarebbe stato possibile disegnare un intervento più efficace?
«Questa nuova misura si aggiunge al già esistente bonus sociale elettrico, i cui aventi diritto sono determinati dai nuclei con un Isee inferiore a poco più di 9mila euro con non più di tre figli a carico (le soglie sono state temporaneamente aumentate a 12mila per il 2022 a partire da aprile, e a 15mila per il 2023). Se si sommano le due misure, le famiglie che beneficiano anche del bonus sociale possono avere bonus fino a circa 440 euro l’anno. A nostro parere si sarebbe potuto avere un effetto redistributivo più importante tenendo in considerazione anche altre caratteristiche, ad esempio, introducendo più soglie Isee in base al numero di figli.
Inoltre, riguardo ad una questione legata all’energia, esso non riflette i reali consumi energetici e quindi non aiuta una famiglia che magari ha una casa inefficiente e con classe energetica bassa e quindi ha grosse spese. In tal senso, il bonus potrebbe essere indirizzato a chi ha al contempo un basso Isee e una casa di classe energetica bassa e delle effettive spese energetiche alte in base alle bollette storiche.
Nonostante questa misura vada nella giusta direzione, pur potendo essere disegnata in modo più mirato, riteniamo sicuramente fondamentale destinare fondi a campagne di informazione che permettano una lettura consapevole delle bollette energetiche e dei contatori, che tutelino i consumatori. Esiste, in vero, il portale delle offerte di Arera dove si possono cercare le offerte più convenienti in base a Cap, consumi medi e altre caratteristiche. Tuttavia, per poterne usufruire è necessario avere già acquisito una discreta conoscenza delle bollette (differenza tra prezzo fisso e prezzo variabile, potenza desiderata, utilizzo di fasce orarie).
Riteniamo che questo sia un primo step per la creazione di Comunità energetiche rinnovabili (Cer) in cui i cittadini siano consapevoli di come ridurre i consumi e utilizzare l’energia in modo efficiente, anche attraverso investimenti come valvole termostatiche per regolare automaticamente la temperatura e la digitalizzazione dei contatori».
Il rapporto Draghi sulla competitività mostra che «nel 2022, all'apice della crisi energetica, il gas naturale ha fissato il prezzo per il 63% del tempo, pur rappresentando solo il 20% del mix elettrico dell'Ue». Qual è oggi la situazione a livello nazionale, e quali sono le strade migliori per disaccoppiare il prezzo dell’elettricità da quello del gas?
«Abbiamo già descritto il funzionamento del Mercato del giorno prima, in cui avviene lo scambio del 75% dell’elettricità. Il funzionamento di questo mercato, dato il mix energetico italiano, fa sì che il prezzo sia spesso determinato dagli impianti a gas. Per eliminare quindi l’influenza dei prezzi del gas si possono percorrere due diverse strade:
- La prima è quella di disaccoppiare i prezzi dell’energia in due mercati, un prezzo marginale per gli impianti non rinnovabili e un prezzo (magari fisso?) per gli impianti rinnovabili. In questa direzione vanno già i contratti a lungo termine come i Contract for differences (Cfd) e Power purchase agreement (Ppa).
- La seconda è quella di creare delle comunità energetiche slegate dal mercato all’ingrosso in cui si scambia l’energia con lo scopo di sottrarre pezzi di domanda al Mercato del giorno prima. Per fare ciò però sono necessari investimenti in accumuli efficienti e in produzione locale di energia rinnovabile.
Per come funziona il mercato ora, gli impianti rinnovabili tanto elogiati per i loro bassi costi di produzione, sono incentivati a non diventare indispensabili perché i primi a guadagnarci dal meccanismo del prezzo marginale sono proprio loro, in quanto producendo energia a basso costo, ricevono profitti pari a chi deve comprare il gas per produrre. E tutto ciò si riflette poi sui nostri costi in bolletta».
Come funzionano i contratti a lungo termine, come Cfd o Ppa, che permettono di far emergere la convenienza economica delle fonti rinnovabili?
«La maggior parte dei volumi di energia vengono scambiati sui mercati a breve termine (circa il 75% di energia viene scambiato durante il Mercato del giorno prima) mentre la restante parte viene scambiata con contratti a lungo termine (15% fuori dalla Borsa e meno del 5% in Power purchase agreement).
I Ppa sono contratti a lungo termine in cui l’acquirente si impegna ad acquistare una certa quantità di energia per un lungo periodo a prezzo fisso. Ciò dà stabilità al produttore che può conoscere quanto guadagnerà in futuro e ridurre il rischio legato all’oscillazione dei prezzi del mercato in Borsa e aiuta gli investimenti. Per come funziona il Mercato del giorno prima, essendo le rinnovabili meno costose, immaginare ad oggi un mercato a sole rinnovabili potrebbe abbattere così tanto i costi da far diminuire drasticamente gli investimenti sugli impianti (chi me lo fa fare di investire nel solare se vendo energia a zero?). Anche i Contract for difference aiutano in questo senso: essi fissano un prezzo di riferimento per il quale se il prezzo di mercato è più basso rispetto a quanto stabilito dal contratto mesi o anni prima, l’acquirente (o lo Stato) copre la differenza e viceversa».
Qual è l’attuale tendenza per questi contratti a lungo termine in Italia, e a quali soggetti di mercato sono rivolti?
«Il numero di contratti a lungo termine Ppa è notevolmente aumentato negli ultimi anni, in Italia si contano circa 50 contratti stipulati, di cui 39 nel 2024, per un totale di circa 2 GW di potenza installata. Tuttavia questi contratti sono stipulati principalmente da imprese, poiché non sono rivolti direttamente ai clienti domestici data la complessità tecnica. Questi strumenti richiedono volumi minimi di energia scambiata troppo elevati per un'utenza domestica, comportano impegni contrattuali di lunga durata e includono numerose complessità burocratiche non proporzionate al profilo di un consumatore residenziale.
Sono auspicabili tuttavia casi virtuosi in cui gli acquirenti di questi contratti sono comunità energetiche o Comuni e Enti della pubblica amministrazione. L’Emilia-Romagna, ad esempio, nel 2022 ha avviato una consultazione preliminare di mercato per valutare l'utilizzo di Ppa per l'acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte delle pubbliche amministrazioni regionali, con l'obiettivo di stabilizzare i costi energetici e promuovere la sostenibilità ambientale attraverso contratti a lungo termine con prezzi fissi.
Il Contract for Difference (CfD), invece, è un contratto che generalmente coinvolge il produttore e lo Stato (o un'entità pubblica), e quindi non è pensato per essere stipulato da un cliente finale domestico. Un cliente residenziale potrebbe comunque trarne un beneficio indiretto, ad esempio aderendo a un contratto di fornitura con un produttore che partecipa a un meccanismo CfD».
Per coniugare l’economicità delle rinnovabili con la possibilità di continuare a investire su queste fonti, occorre dunque riformare l’attuale assetto di mercato – italiano e europeo – con un ribaltamento verso un predominio di contratti Ppa/Cfd, rispetto ai volumi scambiati a breve termine?
«Vista la prospettiva di una sempre più ampia quota di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, ci si troverà (e in parte, soprattutto in alcuni Stati, già ci si trova) di fronte a una problematica a cui ci si riferisce comunemente come paradosso delle rinnovabili. Nello stato attuale, ipotizzando di avere tutta l'energia prodotta da fonti rinnovabili, sarebbero queste a determinare il prezzo marginale che sarebbe quindi zero o addirittura negativo, come già è accaduto in Italia ad aprile 2020 in cui la tecnologia marginale è stata il fotovoltaico. Questo accade perché le fonti rinnovabili hanno un costo marginale per produrre l'elettricità che è pari a zero, perché non paghiamo il sole perché produca l'energia solare e l'acqua affinché scorra. Inoltre, in assenza di accumulatori, per i produttori di energia da fonti rinnovabili, risulta più conveniente pagare il sistema perché prelevi l’energia piuttosto che spegnersi e non produrre, portando così alla formazione di prezzi negativi.
Quindi è sicuramente fondamentale rivoluzionare il mercato elettrico. Ma l’utilizzo di contratti a lungo termine come Cfd e Ppa è una valida soluzione? No.
Pensare di imporre ad impianti rinnovabili i contratti a lungo termine è un rischio: purtroppo si tratta di fonti ad intermittenza (con poche eccezioni) che non possono garantire con certezza i volumi di energia molto tempo prima. Per questo i mercati stanno cercando di ottimizzare gli scambi nel breve termine, nel Mercato infragiornaliero, che è successivo al Mercato del giorno prima e più vicino al momento in cui l’energia deve effettivamente essere scambiata. Questo mercato ha lo scopo di modificare i programmi di produzione e consumo che erano stati fatti nel Mercato del giorno prima e scambiare energia adeguandosi alle variazioni di domanda, offerta e tecnologia più vicine al momento dello scambio effettivo.
Teniamo a mente che se le fonti rinnovabili non riescono a produrre l'energia che avevano venduto (il cielo è nuvoloso e il sole non splende come era stato previsto) si devono attivare impianti, generalmente basati su tecnologie convenzionali, per immettere l'energia in rete, comportando così ulteriori oneri (detti oneri di sbilanciamento) che risultano poi in bolletta tra i costi dell’energia. Questo problema nel lungo termine potrebbe essere risolto con batterie in grado di stoccare l’energia prodotta dalle rinnovabili, ma la tecnologia non è ancora pronta. Il sistema va rivoluzionato ma molto ben pensato, non si può dire che i contratti a lungo termine risolverebbero i problemi, poiché da un lato questi stabilizzerebbero i prezzi, dall’altro, in uno scenario con una forte penetrazione delle rinnovabili, condurrebbero a dei problemi di bilanciamento della rete.
Un'alternativa che si sta considerando a livello europeo è quella di formare un mercato su due livelli (two-tier market) che consiste in una divisione del mercato in un mercato per le tecnologie convenzionali, quelle che utilizzano gas e carbone ad esempio, e un mercato per le tecnologie rinnovabili. Ovviamente anche in questo caso il mercato deve essere disegnato in maniera appropriata perché bisogna stabilire delle nuove regole di mercato che non possono coincidere con il costo marginale».
Secondo i dati messi in fila da Legambiente, l’Italia è in ritardo di 8,1 anni rispetto agli obiettivi 2030 sulle energie rinnovabili. Ma qual è l’iter autorizzativo per arrivare a installare nuovi impianti, e a quale livello di governo si trovano i principali colli di bottiglia?
«Nel 2024, l’Italia ha raggiunto una copertura della domanda da fonti di energia rinnovabile pari al 41,2%, migliorando il 37,8% del 2023. Un segnale positivo, ma non sufficiente. Gli investimenti, in realtà, sarebbero sufficienti, ma l’iter per avviare nuovi impianti è complesso e, poiché le autorizzazioni dipendono dalle regioni, varia da regione a regione.
L’iter consiste in un primo step in cui si presenta la domanda per la Valutazione di impatto ambientale (Via) che può essere di competenza del ministero dell’Ambiente e, più frequentemente, di competenza della regione, e in un secondo step in cui l'impianto fa richiesta di connessione alla rete tramite Terna. Tuttavia, i processi autorizzativi delle regioni sono estremamente lenti, e Legambiente ha stimato che a febbraio 2024 ci fossero 1.376 progetti in attesa di autorizzazione. Questa lentezza è dovuta alla discrezionalità delle regioni e a leggi regionali che spesso sono in conflitto con la normativa nazionale o in conflitto con la tutela del paesaggio e dell’ambiente.
A fine 2024, il Testo unico per le fonti di energia rinnovabile ha modificato la situazione, introducendo delle procedure semplificate a cui le regioni hanno tempo di adeguarsi fino a giugno 2025. Il Testo unico snellisce le procedure ed elimina la necessità di ottenere una Via positiva per gli impianti che non prevedono opere edilizie invasive e per impianti inferiori a 1 MW, salvo casi particolari (ad esempio se l’impianto si trova in area paesaggistica protetta). Adesso aspettiamo i dati del 2025».
Da inizio anno il Pun è stato sostituito da 7 prezzi zonali, che – trascorso il periodo transitorio – garantiranno alle aree d’Italia con più impianti rinnovabili, ben più economici rispetto al gas fossile, prezzi localmente più bassi sulla borsa elettrica. Ci spiega da quali voci è composta la bolletta elettrica, e se i benefici sul prezzo di borsa si tradurranno automaticamente in risparmi per famiglie e imprese?
«Prima di tutto, come già spiegato in precedenza, la quota energia conta, ma è solo una parte di quel che paghiamo in bolletta: essa infatti influisce sul prezzo finale per una quota che varia dal 30 al 50%. Per capire cosa succederà nelle zone, bisogna fare riferimento al funzionamento del prezzo marginale descritto in precedenza. Nelle zone in cui si riesce ad avere il più a lungo possibile l’ultima unità di elettricità prodotta da un impianto rinnovabile (o più efficiente), il prezzo della zona sarà in media inferiore rispetto a quello di una zona con una minore presenza di energia rinnovabile.
Questo meccanismo teoricamente dovrebbe spingere gli operatori ad investire nelle zone dove ci sono meno rinnovabili (il prezzo sarà spesso dato dal gas, quindi si formerà un prezzo più alto, che attira nuovi produttori grazie alla prospettiva di profitti maggiori). Quindi nel breve termine, cioè nell’anno in corso e nel prossimo anno, non vi sarà un’immediata diminuzione dei prezzi, in quanto serve tempo perché dei nuovi produttori entrino nel mercato. Anzi, nelle zone dove l’impianto che stabilisce il prezzo è spesso determinato dagli impianti a gas, il prezzo potrebbe aumentare. Nel lungo termine, cioè negli anni successivi, quando i nuovi produttori avranno costruito i propri impianti rinnovabili, è verosimile che il prezzo medio diminuisca in tutte le zone. Questo porta quindi all'aumento delle fonti rinnovabili e quindi una diminuzione dei prezzi della materia prima energia.
Nel 2023, per esempio, il 54% del totale della produzione termoelettrica, il 41% della produzione da energia solare e il 79% della produzione da energia idrica sono situati nella zona Nord e il 54% della produzione eolica si trova nella zona Sud. Se però andiamo ad analizzare le singole aree per mix energetico, si nota che in tutte le zone la principale fonte di energia è il termoelettrico, con percentuali che variano dal 48% per l’area Centro Nord al 74% dell’area Nord. Quindi è comprensibile che la tecnologia marginale che dettava il prezzo fosse quasi sempre data da impianti termoelettrici a cicli combinati (quindi che utilizzano gas) per tutte le zone italiane. Impianti efficienti ma con costi sicuramente più elevati di impianti rinnovabili.
Se si va a guardare il prezzo medio dell’energia nelle diverse zone nel 2024, i valori vanno da 106€/MWh in Sardegna a 112€/MWh in Sicilia. Pertanto al momento non vi sono importanti differenze di prezzo tra le zone, nonostante ci si debba sicuramente chiedere: è giusto che una persona residente a Palermo paghi un prezzo superiore di chi vive in Sardegna?».