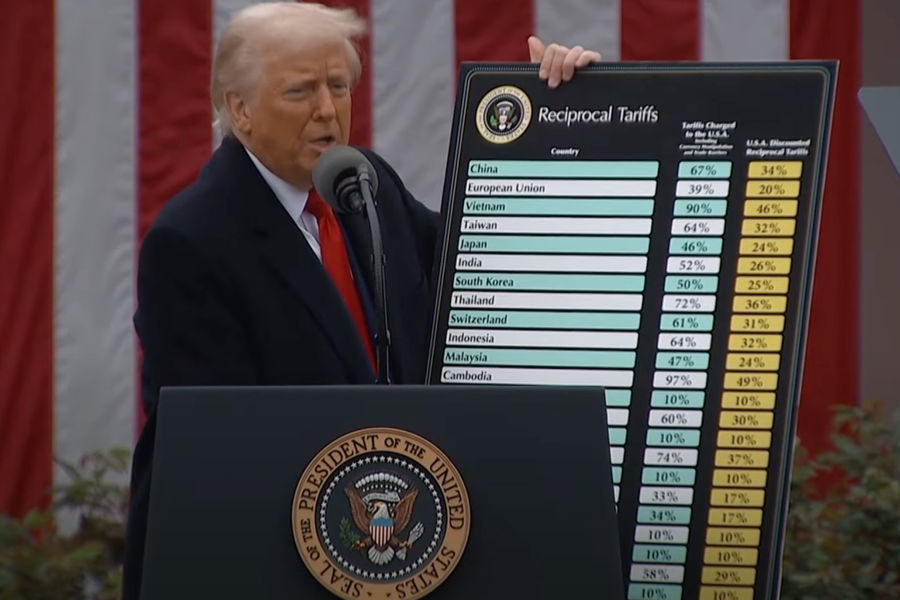Designing with biological and cultural diversities: il progetto Manaona

La proliferazione dei disastri ecologici, le crescenti disuguaglianze sociali, le nuove forme di povertà e i recenti sconvolgimenti geopolitici sono solo alcuni degli eventi che hanno caratterizzato, e continuano tuttora, lo scenario contemporaneo globale degli ultimi anni. La storia ci insegna che, nel manifestarsi di queste crisi dei sistemi socio-ecologici, gli esseri umani tendono sempre a voler cambiare in positivo lo status quo, migliorando le proprie condizioni di vita. Ciò creando alleanze con altri esseri umani e con altri esseri viventi (Haraway, 2019), non potendo farlo da soli.
Tra gli obiettivi e le responsabilità di un essere umano/designer che opera verso la sostenibilità e nella complessità multiforme del reale c'è quello di comprendere il quadro delle trasformazioni contemporanee in atto, attraverso la mappatura delle sfide principalmente eco-sociali che lo attendono.
Come afferma Morton (2018), i problemi e le relazioni che intercorrono tra società, ambiente ed economia - ovvero gli iperoggetti - caratterizzeranno sempre di più le sfide per la sostenibilità e l’inclusione sociale e interculturale del complesso scenario contemporaneo e futuro. La domanda che occorre porsi è quindi: quale può essere il nostro contributo come designer nell’interfacciarci con queste tensioni attuali? Come si trasforma la cultura contemporanea e, soprattutto, quali saranno gli atteggiamenti, i metodi e gli strumenti che l’essere umano/designer dovrà adottare per confrontarsi (o meglio progettare) con comunità diverse, sistemi complessi, processi multiattoriali?
Nella prospettiva di avanzare una possibile risposta ai quesiti posti, il progetto Manaona pone l’attenzione sulla dimensione del fare insieme rappresentato come un’alleanza tra comunità umane e non umane, un’alleanza nutrita dal dialogo tra saperi e culture diverse, da sistemi socio-ecologici sempre più complessi e da processi che diventano sempre più multi-attoriali.
Il progetto prende spunto dal Madagascar, un'isola a metà strada tra l'Africa continentale e il sud-est asiatico, che ha sviluppato una flora e una fauna distintive, con oltre il 90% delle sue specie endemiche che rappresentano il 5% della biodiversità globale (fonti: The Nature Conservancy, Science.org, Convention on Biological Diversity, Biodiversity Finance Initiative). L'isola è abitata dal popolo autoctono Malgascio, che costituisce circa il 96% della composizione etnica dello stato insulare. Il Madagascar è un territorio caratterizzato da un'importante diversità dovuta alla varietà di sistemi eco-naturali e socio-culturali presenti in esso.
Sul fronte sociale, il Madagascar è tra i paesi più poveri del mondo e il suo ricco capitale di diversità biologica esiste come risorsa fondamentale per il futuro sostenibile e il benessere dei suoi cittadini. In questo senso, le diffuse disuguaglianze del contesto socio-culturale ed economico del Madagascar sono profondamente radicate e interconnesse con le attuali minacce alla biodiversità ecologica del Madagascar. In generale, l'economia del paese si basa sulla fauna e sulle specie floreali che forniscono le materie prime per le sue attività produttive. Tuttavia, accade che le funzioni ecologiche e i servizi ecosistemici che garantiscono il benessere e lo sviluppo socioeconomico della popolazione umana indigena siano minacciati dai cambiamenti climatici, le cui ripercussioni sul territorio sono: la deforestazione, il degrado degli habitat naturali, l'erosione del territorio e delle coste, l'esaurimento accelerato delle risorse naturali e la progressiva scomparsa di specie endemiche (fonte: OurWorldInData.org).
Nonostante gli sforzi di conservazione, le minacce alla biodiversità dell’isola malgascia - siano esse di origine eco-naturale o socio-culturale - rimangono preoccupanti, anche a causa del basso livello di investimenti registrati nell'isola da parte di istituzioni nazionali o di partnership straniere. Allo stesso tempo, le diversità biologiche e socio-culturali nutrono e si riflettono nella produzione artigianale locale, caratterizzata da una ricchezza creativa e da una varietà nell'uso di materiali, tecniche, forme, provenienti principalmente dal patrimonio naturale e dalle pratiche di animismo spirituale presenti sul territorio insulare.
Partendo da questa premessa analitica, il team progettuale e di ricerca del Laboratorio di Design per la Sostenibilità (Dipartimento di Architettura - Università degli Studi di Firenze) ha predisposto una fase preliminare di analisi del contesto, strutturata su due livelli:
- stato dell'arte del contesto artigianale malgascio (desk research);
- visita preliminare sul campo (field analysis).
Lo stato dell'arte del contesto artigianale malgascio ha comportato la mappatura delle realtà imprenditoriali e progettuali presenti e in attività, organizzando anche un atlante che potesse fungere da strumento preliminare per l’approfondimento del contesto. I primi dati qualitativi e quantitativi sono stati raccolti grazie alle banche dati internazionali e alla letteratura scientifica presente, utili a dare densità ai contenuti veicolati successivamente in fase di scrittura della proposta progettuale
La visita preliminare sul campo è stato un momento importante per il team di ricerca e progetto per incontrare per la prima volta la cultura malgascia e mettersi in suo ascolto. Per creare le prime relazioni, è stato fondamentale identificare i partner strategici nell'area (enti PA, Università, associazioni sociali, ecc.). Il partner locale Johary Constellation ha coordinato e organizzato il calendario di eventi e incontri previsti durante la settimana di visita sul campo, che ha permesso di entrare in dialogo con diverse aziende e associazioni appartenenti al settore artigianale locale.
Gli incontri individuali sono stati un'occasione fondamentale per realizzare interviste semi-strutturate con alcuni rappresentanti delle aziende e associazioni incontrate, grazie a cui è stato possibile mappare i bisogni del contesto di studio e successivamente identificare i target group di riferimento per il progetto. Come fase successiva alle interviste, sono stati realizzati focus group mirati, in modo informale, per comprendere e valutare i dati quantitativi e qualitativi raccolti inizialmente. Nell'uso di queste metodologie scientifiche, il partner UNIFI ha coordinato le operazioni.
La creazione di questo quadro teorico-critico è stata di fondamentale importanza per identificare i punti di forza e di debolezza del settore manifatturiero artigianale e capire come abbinarli agli interventi di formazione professionale. Ciò che emerge è un settore artigianale ricco di pratiche ancestrali e conoscenze tacite, che peraltro adotta numerose pratiche sostenibili di economia circolare. Esso fa però fatica a comunicare il suo valore aggiunto sia localmente che esternamente al contesto malgascio, incontrando molte difficoltà nell'ingresso nel mercato internazionale in quanto non è supportato da una formazione strategica e professionale. C'è quindi la necessità di mettere in contatto gli artigiani e le imprese locali del settore con i fornitori di formazione professionale locali specializzati nel potenziamento delle competenze e nella comunicazione del valore aggiunto delle produzioni creative sviluppate. Ciò, creando ponti con il mercato nazionale e internazionale relativo al settore artigianale, potenziando le competenze esistenti e dando spazio all'acquisizione di nuove conoscenze e competenze, e adottando strategie di comunicazione più in sintonia con le peculiarità dell'artigianato. la diversità biologica e sociale del contesto in questione.
Proprio per questo motivo il progetto Manaona è stato costruito nell’ottica di un processo di capacity building e community empowerment, con lo scopo di attivare un’azione sostenibile di cooperazione transnazionale attraverso la costituzione di un partenariato multiattoriale e interdisciplinare composto da organizzazioni esperte nel campo della formazione professionale e dell’implementazione di competenze nuove e acquisite.
Il progetto Manaona è stato recentemente presentato nella call dedicata alle attività di capacity building del programma Erasmus+, nella speranza di ricevere i fondi necessari a proseguire i lavori indirizzati al progetto e sviluppo di un ecosistema attivo, sostenibile e inclusivo rispetto alle dinamiche di sviluppo ecologico, socio-culturale ed economico.
La prospettiva futura e forza motrice del progetto è soprattutto quella di contribuire al miglioramento dello status quo, contribuendo (seppur in minima parte e secondo le risorse e conoscenze a disposizione) alla riduzione della povertà, alla lotta contro tutte le disuguaglianze e alla crescita economica sostenibile.
a cura di Margherita Vacca
Bibliografia
Aime, M. (2004). Eccessi di culture. Torino: Einaudi.
Descola, P. (2010). Diversità di natura, diversità di cultura. Milano: Book Time.
Glissant, E. (1998). Introduzione a una poetica del Diverso. Milano: Meltemi.
Glissant, E. (2007). Tutto-mondo. Roma: Edizioni Lavoro.
Han, B.-C. (2017). L’espulsione dell’Altro. Milano: Nottetempo.
Haraway, D. J. (2019). Chthulucene. Sopravvivere su un pianeta infetto. Roma: NERO editions.
Lotti, G. (2012). Progettare con l’Altro. Necessità, opportunità. Pisa: Edizioni ETS.
Lotti, G. (2015). Design Interculturale. Progetti dal mare di mezzo. Firenze: DIDA press.
Manzini, E. (2015). Design when everybody designs. An introduction to Design for social innovation. Cambridge: The MIT press.
Morton, T. (2018). Iperoggetti. Filosofia ed ecologia dopo la fine del mondo. Roma: NERO editions