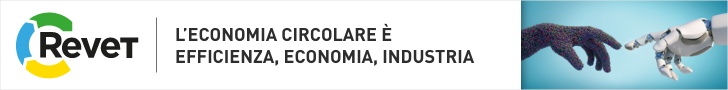Il Piano per salvare l'acqua d'Italia dalla crisi climatica vale 176,5 mld di euro in 10 anni
Tutte le principali sfide che l’Italia è chiamata ad affrontare nell’era della crisi climatica convergono sull’acqua. Sia quando scarseggia (la desertificazione avanza col 17,4% dei suoli nazionali già degradato e 12 Regioni in stress idrico elevato) sia quando è troppa (con 7 milioni di cittadini a rischio alluvioni).
La buona notizia è le risorse idriche teoricamente a disposizione del Paese superano di molto i fabbisogni, e continueranno a farlo nei prossimi decenni: dobbiamo però imparare a gestirle, e le nuove tecnologie rappresentano strumenti formidabili per farlo in modo sostenibile.
È quanto emerso con chiarezza nel corso del convegno apertosi stamani – organizzato da Proger in collaborazione con la Fondazione Italiadecide e ospitato nella sede di Confagricoltura – per presentare Water intelligence, il primo report nazionale sull’innovazione tecnologica e la digitalizzazione nella gestione del ciclo dell’acqua.
Il rapporto vede come autori il direttore editoriale di greenreport e presidente della Fondazione earth and water agenda (Ewa), Erasmo D’Angelis, insieme al direttore di Ewa Mauro Grassi; realizzato per l’Osservatorio Proger sulle infrastrutture del futuro, rappresenta l’ideale continuazione del rapporto Water economy pubblicato un anno fa.
Il punto di partenza è incoraggiante: le precipitazioni complessive sull’Italia (pioggia, neve, grandine) ammontano a 296 mld di mc/anno nel periodo 2010-2023, in leggero calo rispetto ai 300 registrati dal 1951-1970.
In media circa la metà di questi volumi è indisponibile a causa dell’evapotraspirazione – un dato in robusta crescita a causa del riscaldamento globale, che porta al contempo a eventi estremi più intensi e frequenti come nel caso delle alluvioni –, ma di acqua a disposizione ne resta in abbondanza.
Il totale dei prelievi d’acqua per usi antropici (servizio idrico, agricoltura, industria) vale oggi 34,2 mld di mc/a – meno che nel 1970 (41,9) – di cui 26,6 sono effettivamente usati mentre 7,6 si perdono per strada a causa di un’inefficienza delle reti che grida vendetta.
Nonostante ciò, confrontando la serie storica Ispra delle precipitazione nei “mesi piovosi” e quella nei “mesi secchi”, tenendo conto dei fabbisogni d’acqua sia per usi antropici sia per la vita ecologica di fiumi e laghi, emerge che l’Italia vanta oggi un surplus idrico pari a 63,6 mld mc. Un dato che sarà quasi dimezzato nei prossimi decenni a causa della crisi climatica, restando comunque assai solido: 35,5 mld mc al 2050.
Risulta dunque evidente che le siccità che ciclicamente si ripetono nel Paese – quella in corso in Sicilia, ad esempio, sta mettendo a rischio il 75% della produzione agricola locale – si alternano alle alluvioni, senza che il Paese sia dotato di infrastrutture adeguate a stoccare l’acqua quando è in eccesso e a distribuirla quando non piove.
Negli ultimi 20 anni l’Italia ha attraversato 9 gravi fasi di siccità con costi complessivi per circa 30 miliardi di euro, mentre solo nel 2023 le alluvioni che hanno colpito Emilia Romagna e Toscana hanno provocato danni per 11,6 mld di euro.
Se questi sono i costi imposti dalla crisi climatica, investire in prevenzione risulta assai più conveniente oltre ad essere una strategia indispensabile a tutelare sia il benessere dei cittadini sia l’equilibrio degli ecosistemi.
Per finanziare un Piano nazionale per la sicurezza idrica e idrogeologica, come illustrato dal rapporto Water intelligence, servirebbero 17,7 mld di euro l’anno per un decennio, arrivando a un totale di 176,5 mld di euro.
Si tratta di un Piano omnicomprensivo: si va dagli investimenti sul servizio idrico integrato alla realizzazione di 20 nuove dighe e 5mila piccoli invasi, fino all’aumento della produzione idroelettrica; dal disinterramento delle dighe già esistenti al finanziamento di dissalatori alle infrastrutture per il riuso dell’acqua; dalle soluzioni basate sulla natura per la ricarica delle falde come per la realizzazione di città-spugna; dagli interventi di difesa contro il rischio idrogeologico alla manutenzione del reticolo fluviale; tecnologie, monitoraggi, ricerca e investimenti sulla Protezione civile completano il quadro.
Si tratta, in sintesi, di rispolverare l’antica sapienza che nel corso dei millenni l’Italia ha sempre saputo produrre nella gestione della sua ricchezza più importante, quella idrica.
Negli ultimi 20 anni lo Stato ha investito tra l’1 e il 2% della spesa pubblica nazionale sull’acqua, una sostanziale irrilevanza confermata anche nel Pnrr con investimenti pari a 4,3 miliardi di euro sul totale di 238 miliardi; anche le basse tariffe del servizio idrico producono una media di investimenti per abitante all’anno pari a 67 euro, a fronte di valori medi intorno a 120 euro nell’Europa più avanzata.
Eppure la civiltà dell’acqua ha avuto inizio circa 13 mila anni fa, quando le popolazioni sull’altopiano di Matera riuscirono ad imporsi come “addomesticatori” di acque per raccogliere e incanalare la risorsa preziosa. I sardi delle culture pre-nuragiche si sono rivelati i primi scavatori di pozzi. L’Impero romano ha rivelato la sua grandezza con acquedotti, terme, fognature e bonifiche. E così via, nel corso dei secoli. Oggi, in piena crisi climatica, gli italiani non possono valere meno dei loro illustri antenati.
Pubblichiamo di seguito in allegato l’Executive summary del rapporto Water Intelligence
PDF allegati