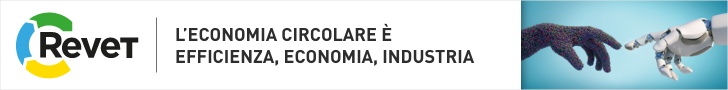Degrado del suolo e siccità: ripristinare la natura è il test per la nostra generazione

La terra è il fondamento delle nostre società ed è una pietra angolare per la sicurezza alimentare globale e la salute ambientale, la fame zero, l'eliminazione della povertà e l'energia accessibile a tutti a un prezzo equo. È alla base del successo dell'intera Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile dell’Onu, eppure questa risorsa finita è minacciata dalla stessa umanità che ne usufruisce.
Come spiega l’Onu, «A livello globale, un quinto della superficie terrestre – più di 2 miliardi di ettari – è degradato, compresa più della metà di tutti i terreni agricoli. Ogni anno, più di 12 milioni di ettari di terreno vengono persi a causa della desertificazione, del degrado del suolo e della siccità (DLDD). Il mondo perde ogni anno 24 miliardi di tonnellate di suolo fertile a causa del degrado delle terre aride, con significativi impatti negativi sulla produzione alimentare e sull'attività economica».
Aprendo, l’High-level Dialogue on Desertification, Land Degradation and Drought, il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, ha detto che «Il nostro pianeta è malato, il degrado del suolo colpisce circa 3,2 miliardi di persone, il 70% della terra mondiale è stata trasformata dall'attività umana. Chiedo un nuovo contratto sulla natura attraverso l'azione internazionale e la solidarietà. Possiamo aumentare il ripristino del territorio e le soluzioni basate sulla natura per l'azione climatica e a beneficio delle generazioni future».
Attualmente, il degrado del suolo ha un forte impatto sul benessere di 3,2 miliardi di persone, oltre il 40% dell'intera popolazione mondiale. La Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) stima che oltre il 70% di tutte le terre naturali libere dai ghiacci sia stato trasformato dall'attività umana, devastando la biodiversità globale. Secondo l’IPCC Special Report on Climate Change and Land, anche la produzione di cibo, mangimi e fibre contribuisce in modo significativo al cambiamento climatico, con circa un quarto delle emissioni di gas serra provenienti da agricoltura, silvicoltura e altri utilizzi del suolo.
Il cambiamento climatico aggrava ulteriormente - e viene a sua volta aggravato - da un utilizzo non sostenibile del suolo, con molte regioni che soffrono di siccità più frequenti e prolungate. La siccità e i cambiamenti climatici stanno facendo aumentare gli incendi boschivi che, solo dal 2018 al 2020, hanno devastato più di circa 120.000 Km2 di territorio nel nord e nel sud del mondo, causando perdite significative in mezzi di sussistenza, salute e biodiversità.
il presidente uscente dell'Assemblea generale dell’Onu, Volkan Bozkir, ha chiesto «Una maggiore cooperazione internazionale per combattere il degrado del suolo che minaccia i mezzi di sussistenza e la sicurezza di tre miliardi di persone. Ho convocato questo dialogo per galvanizzare la cooperazione internazionale per prevenire un ulteriore degrado e far rivivere le terre degradate. Oggi la metà di tutti i terreni agricoli è degradata. La perdita di terra sana porta all'estinzione e intensifica il cambiamento climatico, perché la terra sana è il più grande pozzo di carbonio del mondo. Senza un cambio di rotta, andrà solo peggio. Entro il 2050, si prevede che i raccolti globali diminuiranno del 10% e in alcuni casi la riduzione potrebbe arrivare fino al 50%. Ciò porterà a un forte aumento del 30% dei prezzi alimentari mondiali. Mentre più della metà del PIL mondiale dipende dalle risorse della terra, milioni di agricoltori rischiano di cadere in povertà se si perde più terra coltivabile».
Infatti, le agenzie Onu prevedono che «Il degrado del suolo indotto dal clima e lo stress idrico impoveriranno sempre più terreno coltivabile nei prossimi anni, facendo sprofondare milioni di agricoltori nella povertà e contribuendo alla migrazione forzata e ai conflitti». Entro il 2025, due terzi del mondo potrebbero vivere in condizioni di stress idrico, con 1,8 miliardi di persone che sperimenteranno un'assoluta scarsità d'acqua. E’ anche probabile che la migrazione aumenti a causa della desertificazione, con stime che la pongono tra la principale causa dell’emigrazione di circa 135 milioni di persone entro il 2045.
Bozkir ha descritto il ripristino della natura come «Il test per la nostra generazione» e ha delineato quale sarebbe il costo dell'inazione: «Il nostro pianeta sta affrontando una crisi ambientale che abbraccia ogni aspetto del mondo naturale: terra, clima e biodiversità e inquinamento terrestre e marino. La nostra esistenza e la nostra capacità di prosperare in questo mondo dipendono interamente da come ripristiniamo e ricostruiamo il nostro rapporto con il mondo naturale, inclusa la salute della nostra terra. Senza un cambiamento di rotta, le cose andranno solo peggio».
Come se non bastasse, il cambiamento insostenibile dell'utilizzo del suolo, inclusa la deforestazione, è stato identificato come il principale motore delle malattie infettive emergenti. Come affermato dalla risoluzione 75/218 dell'Assemblea generale dell’Onu, «La lotta alla desertificazione, al degrado del suolo e alla siccità e il raggiungimento della land degradation neutrality sono fondamentali per accelerare il raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile per proteggere i mezzi di sussistenza, prevenire e prepararsi a future pandemie e ricostruire meglio dopo il Covid- 19. Per ogni dollaro speso per il ripristino del territorio, anche attraverso progetti a bassa specializzazione e ad alta intensità di manodopera, ci si possono aspettare almeno 9 dollari di benefici economici. Gli sforzi di ripristino dell'ecosistema su larga scala hanno il potenziale per creare fino a 40 posti di lavoro per ogni milione di dollari investiti».
Uno degli sviluppi più importanti ottenuti durante l’United Nations Decade for Deserts and the Fight against Desertification (2011-2020) è stata la notevole espansione delle conoscenze scientifiche sui fattori, i processi e gli impatti della DLDD. Sono stati compiuti notevoli progressi tecnici nello sviluppo di soluzioni a queste sfide.
L’Onu evidenzia che «Garantire la sicurezza alimentare della popolazione mondiale di dei 9,7 miliardi prevista per il nostro pianeta entro il 2050 e attuare contemporaneamente l'Accordo di Parigi, sarà impossibile senza affrontare il degrado del suolo e attuare una riforma del sistema alimentare. Questo aignificherà potenziare le iniziative di Land Degradation Neutrality (LDN), garantire i diritti di proprietà della terra per le agricoltrici responsabili del 60 - 80% della produzione alimentare nei Paesi in via di sviluppo e combattere la siccità e gli incendi boschivi. L'inclusione di un obiettivo specifico nell'SDG 15 ("Life on Land"), per raggiungere la LDN entro il 2030, riflette l'impegno della comunità internazionale a compiere progressi nel ripristino del suolo e nell'invertire il degrado del suolo. Oltre 120 Paesi si sono già impegnati a fissare obiettivi volontari per raggiungere la neutralità del degrado del suolo».
Nel suo intervento, Ibrahim Thiaw, segretario esecutivo dell’United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD) ha fatto notare che «Ripristinare il nostro pianeta richiede un'azione e un'ambizione decisive su molte questioni interconnesse: affrontare il cambiamento climatico, ridurre i consumi e ripristinare la salute della nostra terra e dei nostri ecosistemi.
Mentre è iniziata la Decade of Ecosystem Restoration dell’Onu, Bozkir ha ricordato che i Paesi dovrebbero anche applicare le lezioni apprese nella Decade to Fight Desertification: «Il ripristino del territorio deve essere al centro dei processi internazionali esistenti, come i Nationally Determined Contributions (NDC) per combattere i cambiamenti climatici, il Global Biodiversity Framework post-2020 e i piani di ripresa e di stimolo post Covid-19. Poiché l'"agricoltura insostenibile" è il principale motore della desertificazione, invito i governi a condurre dialoghi nazionali sulla riforma agricola in vista del Food Systems Summit di settembre».
Il presidente dell'Assemblea generale dell’Onu ha anche sottolineato «La necessità di una maggiore sinergia tra pace, sviluppo e azione umanitaria, con gli O biettivi di sviluppo sostenibile che fungono da roadmap. La cooperazione in questo campo può essere raggiunta attraverso l'attuazione universale del Sendai Framework for Disaster Risk Reduction che migliorerà gli sforzi di prevenzione».
Inoltre, per Bozkir è necessario destinare una quota maggiore dei finanziamenti per il clima alle foreste e all'agricoltura: «Per una cifra stimata di 2,7 trilioni di dollari all'anno – comodamente proponibile nell'ambito della spesa post-Covid – potremmo trasformare le economie del mondo ripristinando gli ecosistemi naturali, premiando l'agricoltura che mantiene sani i suoli e incentivando modelli di business che danno la priorità a prodotti e servizi rinnovabili, riciclabili o biodegradabili. Entro un decennio, l'economia globale potrebbe creare 395 milioni di nuovi posti di lavoro e generare oltre 10 trilioni di dollari. Non vanno inoltre dimenticati i diritti di oltre un miliardo di lavoratori agricoli nel mondo. La maggior parte non possiede le terre su cui lavora, poiché attualmente l'1% delle aziende agricole controlla oltre il 70% delle terre coltivabili del mondo. Investire direttamente nei lavoratori della terra è un investimento nella nostra terra e nel futuro del nostro pianeta. Quando permettiamo ai lavoratori di investire nella loro terra, sosteniamo la produttività agricola. La tutela dell'ambiente, la generazione di ricchezza, la partecipazione civica e lo stato di diritto ne beneficiano, in particolare i produttori indigeni e su piccola scala, comprese le contadine».
Per evidenziare l'importanza del suolo per la sopravvivenza, Bozkir ha dato a ciascun rappresentante all’Onu una piantina di basilico, insieme alla richiesta di aggiornarlo sulla loro crescita e ha concluso: «Se eleviamo l'azione per il territorio oggi, possiamo salvaguardare la sicurezza alimentare e idrica globale, ridurre le emissioni, conservare la biodiversità e proteggerci da futuri rischi sistemici per la salute e l'ambiente. In parole povere, il suolo è la soluzione».