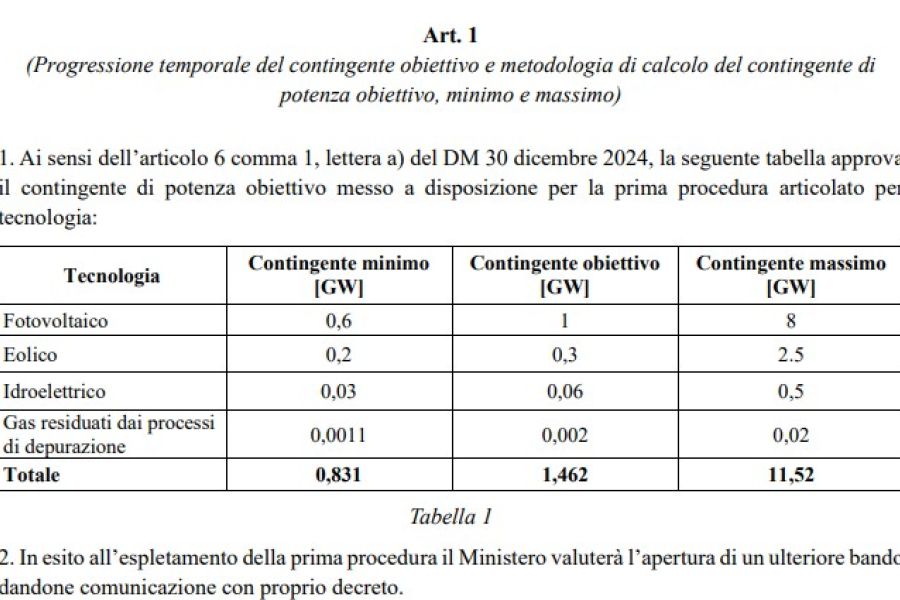Come produrremo (e consumeremo) energia in futuro?

In un mondo in cui la connettività conta più delle dimensioni, come dice Parag Khanna, stratega geopolitico, per pensare e riflettere su quella che sarà l’energia del futuro bisogna non più approcciare il fenomeno da un punto isolato, che può essere la nostra nazione, ma da una visione seriamente globale. Bisogna capire (e i vari incontri sul clima ce lo dovrebbero dimostrare, così come l’elezione di Trump negli USA) che quello che molti chiamano banalmente “effetto farfalla”, ovvero il propagarsi delle conseguenze di un evento in paesi a milioni di km di distanza rispetto a dove lo stesso viene generato, diventa il punto di riferimento. Man mano che le popolazioni si connettono tra loro, le intelligenze si concentrano sempre in quelle che possiamo chiamare, citando ancora Khanna, "global cities".
Pensiamo alle carni alimentari, alle importazioni di prodotti e alle strategie marketing che sembrano nascere in Cina o in USA e oggi arrivano in maniera molto più veloce rispetto al passato in ogni parte del mondo. Se dobbiamo fare un decorso serio in tale direzione dobbiamo capire che studi sull’energia o “cappelli” messi sul futuro possono avere senso solo se la diffusione dell'energia si apre ad una scala globale, in cui gli standard obbligatori relativi provengono da normative e riferimenti internazionali e non locali.
Gli impegni assunti dalla COP22, ultimo degli incontri annuali sui cambiamenti climatici, ce lo dimostrano. Ma nel frattempo c’è qualcosa che stride. Si inizia a giocare con i numeri, o meglio con le date e con gli approcci. Partiamo da questi ultimi: le questioni sul clima, con annessi e connessi, riguardano più indicatori e non il solo problema. Il focus energetico (elettrico e gas), il problema dei rifiuti, l’aumento della popolazione, il divario tra ricchezza e povertà degli stati, lo scioglimento dei ghiacci, il movimento degli animali e così via: sono tutti fenomeni che hanno un legame inscindibile tra loro e sono propedeutici per capire il fenomeno in generale. Ad esempio, per dirne una, se non sappiamo quante persone e aziende hanno bisogno, in un determinato territorio, di energia, rispetto a quello che si produce in quello stesso territorio, non riusciamo ad inquadrare il problema nella sua globalità.
Riguardo ai dati, le cose non è che vadano meglio. Al di là dei proclami sui social di pseudo-esperti che pubblicano dati ogni giorno quasi attendendo il miracolo, dobbiamo dire che con il protocollo di Kyoto del 1997, vero spartiacque in tema di cambiamenti climatici, si è tentato di “bloccare” la crescita della temperatura media globale sulle terre emerse e sulla superficie degli oceani ad un massimo di +2 gradi centigradi. Ai tempi si era posto come deadline l'anno 2020.
Il World Energy Outlook 2016 (WEO), come ci riporta l’IEA, International Energy Agency, con dati ancora provvisori per il 2016, ma definitivi per il 2015, ci parla di un nuovo slancio alla transizione "verso un sistema energetico a più bassa intensità di carbonio e più efficiente", senza però registrare un'alterazione del trend di continua crescita dei fabbisogni energetici globali. Quindi, mentre crescono i fabbisogni, le richieste per intenderci, ancora non siamo riusciti a produrre quanto basta. O perlomeno, in prospettiva, non siamo capaci di organizzare bene la produzione, ora diversa.
Da questa prima riflessione abbandoniamo ogni speranza quindi per il 2020. Analizzando lo scenario globale, ci si aspetta che la domanda mondiale di energia, sempre secondo il WEO, aumenti di un terzo al 2040, con l’incremento principalmente guidato da India, Cina, Africa, Medio Oriente e Sud Est asiatico. Nel documento di riferimento, IEA dice espressamente che "la crescita attesa dei consumi mondiali viene interamente assorbita dall’insieme dei paesi non-OCSE mentre i trend demografici e i cambiamenti strutturali dell’economia, unitamente ai miglioramenti di efficienza, determinano una riduzione complessiva della domanda OCSE rispetto al picco raggiunto nel 2007. Il calo è guidato da Unione Europea (-15% lungo l’orizzonte di proiezione), Giappone (-12%) e Stati Uniti (-3%). In molti paesi, i suddetti impegni incentivano l’uso di fonti e tecnologie a più bassa intensità di carbonio, con la quota delle fonti non fossili che passa dall’attuale 19% al 25% del mix energetico mondiale nel 2040. Tra i combustibili fossili, solo il gas naturale – quello a minore intensità carbonica – registra un aumento del suo peso relativo”.
Il WEO, dal canto suo, dice che "entro il 2030 il consumo di energia pro capite raggiungerà il suo picco e, secondo le proiezioni contenute nello scenario più ottimistico, al 2060 il fabbisogno mondiale di energia primaria rallenterà sensibilmente”. Questo grazie ad un’ urbanizzazione più capillare e una crescita della classe media, soprattutto in Asia, che contribuiranno a diffondere consumi energetici sempre più caratterizzati da grandi consumi di elettricità.
Ma diamo uno sguardo sulla produzione di energia elettrica: ad oggi le rinnovabili coprono tra il 23% e il 30% a livello mondiale, se intendiamo il mix energetico (compreso idroelettrico); per quanto riguarda la produzione di petrolio, non è destinata affatto a sparire, anzi, si raggiungerà il picco nel 2030 con una produzione massima compresa tra i 94 e i 103 milioni di barili al giorno, per arrivare, nel 2040, a 104 milioni di barili al giorno. Tuttavia, la mobilità a basso tenore di carbonio, secondo quanto contenuto nel WEO16, se ci saranno i presupposti, farebbe crollare in futuro l’utilizzo del petrolio nel settore dei trasporti dal 92% di oggi al 60% entro il 2060. Inoltre, i biocarburanti andrebbero a coprire una quota del 21% del mix energetico dei trasporti, mentre i veicoli elettrici potrebbero rappresentare un terzo del parco veicoli entro il 2060. Per il carbone, probabilmente già entro il 2020, si raggiungerà il picco, ma la verifica è determinata dalle scelte di politica energetica di India, Cina e Usa.
Insomma i report seri (e non riflessioni di enti improvvisati) ci offrono un amaro presagio riguardo alle emissioni climalteranti: si stima che si potrebbe giungere alle 1000 Gt di CO2 prima del 2040. Nelle note di tali report si specifica che nel periodo 2014-2060 l’aumento della popolazione mondiale, unito a una diffusa crescita economica, favorirà l’incremento della CO2 in atmosfera. Il panorama più drammatico - caratterizzato dall’assenza totale di una politica climatica globale - prevede nel 2060 un aumento complessivo del 5% delle emissioni rispetto ai valori registrati nel 2014.
Secondo tutte queste premesse, come già ci aveva avvertito la Francia, nel 2060 potremmo avere quindi un pianeta più caldo di ben 3 °C in confronto alle temperature del passato preindustriale.
Se il futuro dell'energia si prospetta così tragico, bisogna capire quali e come saranno le energie del futuro, con un approfondimento anche di quello che sarà il modello di sviluppo dei paesi e i loro rapporti, i sistemi di approvvigionamento e la futura gestione dell’energia. Dico questo perché, tecnicamente, ogni paese a livello internazionale ha una conformazione propria che oggi più che mai nasconde vulnerabilità in tutto il sistema e prima di tutto dobbiamo capire come far interagire queste diversità e come, nelle stesse differenze, poter scambiare attivamente ciò che si produce.
Ma quali possono essere le fonti? Tre sono le possibili energie del futuro: sole, acqua e energia in rete.
Partiamo dalla prima: il sole. Basterebbe una solarizzazione parziale di una regione di qualsiasi paese per avere una capacità di captazione quasi 10 volte superiore alla cattura iniziale: facendolo con il solo Abruzzo ad esempio si potrebbero irraggiare di energia termica ed elettrica circa 10 altre regioni italiane. Solarizzare le zone in futuro non deve passare attraverso il fotovoltaico attuale, tecnica del 1839, ma servirsi di applicazioni a radiazione ad alto rendimento, oltre il 60%, e non legato al silicio, ma al grafene ad esempio.
Già nel 2013 al CNR, e prima ancora nel 2011 in Enea, si è scoperto che il grafene, una volta colpito da impulsi luminosi molto brevi, provoca un processo di moltiplicazione a cascata degli elettroni. Non dimentichiamo che il grafene è 100 volte più resistente dell’acciaio e non ha bisogno di manutenzione nei tempi e nei modi del silicio. All’Università di Oxford, Department of Materials, stanno addirittura utilizzando l’esfoliazione chimica del grafene per tutte le sue applicazioni nell’elettronica. Si sta cercando di recuperare anche il vapore chimico dello stesso per generare energia termica. Bisogna individuare una strategia di sviluppo che escluda il fatto di utilizzare ampi spazi per produrre di più, in quanto basterebbe una concentrazione maggiore in piccoli spazi. L’incremento generale della riduzione ad impatto zero deve seguire un processo ben preciso e deve permettere agli studiosi di condividere e studiare i fenomeni insieme. Stessa cosa per l’idroelettrico con in più quella che possiamo chiamare “compensazione ambientale”. Ovvero, sfruttare nelle regioni con ampi flussi di acqua delle canalizzazioni che permetterebbero, attraverso dei salti studiati ad hoc e con un edificio al centro fatto con materiali di scarto e recupero, la produzione abbondante di energia e, nello stesso tempo, la razionalizzazione del livello dell’acqua, evitando problemi di inondazioni e straripamenti di dighe in pericolo. In tale contesto, sarebbe più opportuno disincentivare le ESCo e il loro meccanismo perverso di accollarsi gli investimenti di riqualificazione mai andati a buon fine con le Pubbliche Amministrazioni, e dare invece largo spazio alle cosiddette Energy Performance Contract (EPC). Queste ultime, con un investimento al 50% (il restante 50% dalle imprese) riescono a ottenere il rendimento energetico “necessario” dalle strutture riqualificate, di cui già in partenza si ha garanzia del risultato sulla produzione di energia.
Passiamo alla seconda energia del futuro: l’acqua. La possibilità di canalizzare l’acqua piovana con quella dei torrenti con più opere di presa nel flusso e salti aumentati, può permettere di generare meno velocità, ma più quantità, che produrrebbe, in determinati periodi dell'anno, vapore favorevole per una migliore gestione della qualità dell'acqua (con vasche ad hoc), che potrebbe diventare anche produzione di calore.
La tecnologia adatta sarà una macchina volumetrica a variazione. Ancora non in uso, permetterebbe di risolvere il problema dell'altezza delle acque, aumentando l’efficienza della centrale e consentendo una regolazione del carico più fluida. Un convertitore di frequenza avrebbe il ruolo di smistatore di energia in eccesso.
La terza strada: energia stoccata in rete, ossia la messa in rete e riattivazione di quegli impianti fotovoltaici ormai obsoleti o poco produttivi, confermando così la possibilità di far dialogare in maniera diretta energie date dal surplus che oggi non godono più di incentivo. La messa in rete potrà essere fatta con la connessione virtuale attraverso wi-fi, di cui parleremo la prossima volta nello specifico, ricordando il famoso fisico Tesla. Qui si gioca il fronte tra produzione e distribuzione. Non devono essere aspetti divisi. Produrre vuol dire continuare a scavare, trovare, raffinare, sfruttare il pianeta o ricavare il meglio da ciò che abbiamo già prodotto per sfruttarlo nuovamente e saperlo distribuire allo stesso momento. Ad esempio, in tal senso, si potrebbe iniziare a parlare di condivisione in grid parity (mettendo in parità il fabbisogno reale e il consumo) della distribuzione dell'eccesso di energia, producendo anche più posti di lavoro per la gestione della regolamentazione.
Un passaggio delicatissimo ulteriore sarà quello della ripartizione dell’obiettivo comune fra i vari stati dell'energia stoccata. In tutto questo contesto che si dovrebbe aprire non si è ancora utilizzato né il criterio delle credibilità (vedi differenze di incentivi in tutto il mondo sull’incremento delle fonti rinnovabili) né il criterio di aspettativa economica delle risorse per la realizzazione degli interventi. Si è preferito, in generale, come si diceva prima, lo sviluppo incondizionato delle tecnologie in nazioni (quindi anche nelle loro città) che forse avevano bisogno più di applicazioni a forte impatto quotidiano e calato nella singola realtà, che non tecnologie intelligenti, ma solo fine a sé stesse. Ne sono un esempio le sperimentazioni fatte con i semafori intelligenti, che non hanno dato una soluzione al traffico, e i lampioni intelligenti che sono più quelli che non funzionano che quelli che vanno. Da qui il vero problema internazionale.
Se si leggono gli abstract dei programmi quadro di ricerca (da quelli dell’UE a quelli degli Stati non membri) la prima cosa richiesta è proprio la replicabilità delle tecnologie e del progetto. Un fallimento. Un esempio su tutti di questo atteggiamento da modificare è la favola delle smart city. Si tende a esportare innovazioni, grandi scoperte e applicazioni varie andate “bene” in alcune città, in altre che hanno geografia, persone, strade, vie, automobili completamente diverse. Tra i tanti vertici internazionali, si è perso il senso dell’indicizzazione delle buone pratiche, la contestualizzazione degli interventi e la loro genialità. Insomma, tre strade abbozzate, il cui segnale è dare più certezze alla gente e non solo agli investitori, incoraggiare non in maniera tout court lo sviluppo tecnologico per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ma far capire come impattano ed interagiscono con noi.
Per concludere, basterebbe creare un approccio davvero globale di competenze e uno scambio di pertinenze, agendo con un protocollo comune laddove ce n’è un bisogno reale, ovvero in scuole e università, ma questo non accade.
Il premio Nobel statunitense Joseph Stiglitz ha dichiarato: “prima degli anni ‘80 crescevano insieme produttività e paga oraria. Dalla fine degli anni ‘70 c’è stato un cambiamento: la produttività ha continuato a crescere, ma i frutti di quella produttività sono andati all'1% della popolazione più ricca, mentre contemporaneamente nulla è andato agli operai, ai lavoratori che hanno fatto quella produttività”. Ciò significa che bisogna spostare l'attenzione da una gestione del commercio delle cose in mano di pochi ad un accordo internazionale di libero scambio. Con tale accordo da una parte le tariffe della quota energia (ovvero ciò che paghiamo sulle bollette come consumo) si abbasserebbero, dall'altra si potrebbero abbattere anche i costi fissi poiché si regolarizzerebbero meglio le norme ambientali e quelle sulla sicurezza.
di Marco Santarelli, Direttore Ricerca&Sviluppo, Network – Istituto internazionale di Alti studi per Infrastrutture critiche e Energie del futuro” Associato per enti di ricerca internazionali