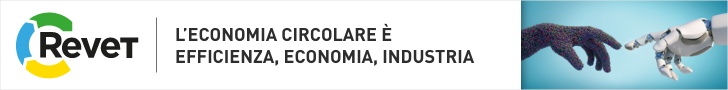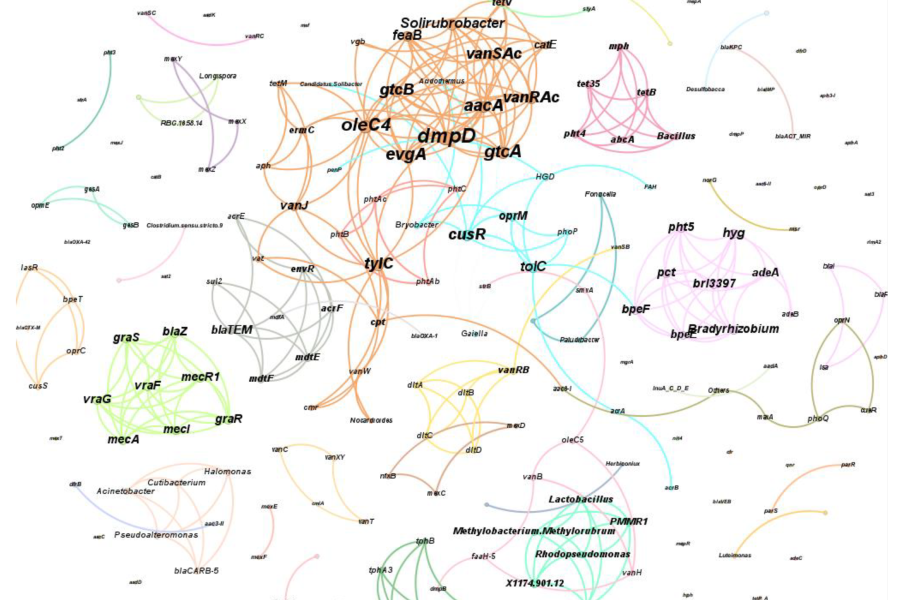Sull’inquinamento atmosferico in Toscana pesano anche gli effetti della crisi climatica

Il Direttore generale e il Direttore tecnico di Arpat, Pietro Rubellini e Marcello Mossa Verre, hanno preso parte ieri mattina, su invito del Presidente di Legambiente Toscana Fausto Ferruzza, alla conferenza stampa Mal’Aria di città 2025, il consueto rapporto che annualmente l’associazione elabora a partire dai dati forniti dalle Agenzie ambientali per tracciare luci ed ombre dell’inquinamento atmosferico nelle città italiane.
L’Agenzia, a tal proposito, ha recentemente pubblicato le prime elaborazioni dei dati raccolti dalla Rete regionale di monitoraggio della qualità dell’aria della Regione Toscana nel 2024, analizzando gli inquinanti storicamente più critici, ovvero particolato, biossido di azoto e ozono. Dall’analisi emerge che nel 2024, mentre PM10 e ozono hanno riportato le stesse criticità osservate negli ultimi anni, gli indicatori annuali relativi al biossido di azoto, per il primo anno dall’inizio del monitoraggio, hanno rispettato i limiti normativi in tutta la regione, compresa la stazione di traffico FI-Gramsci, che negli anni precedenti aveva fatto registrare superamenti normativi.
La conferenza di ieri è stata anche l’occasione per confrontarsi su queste prime elaborazioni. Ad Andrea Minutolo, responsabile scientifico Legambiente, è andato il compito di presentare il rapporto nazionale Mal’Aria 2025 mentre a Fausto Ferruzza di commentare i dati emersi a livello regionale.
Il Direttore generale Pietro Rubellini, ringraziando Legambiente per l’iniziativa e sottolineando la condivisione di un comune approccio tecnico scientifico, che permette all’Agenzia e all’Associazione di avere un confronto sempre interessante e proficuo, ha evidenziato come i dati sulla qualità dell’aria 2024 facciano registrare un miglioramento, consolidando la tendenza positiva in atto già da diversi anni.
«Nel 2024 – ha affermato Rubellini – per alcuni inquinanti la situazione si rivela stazionaria ma assistiamo anche ad alcuni miglioramenti che sono, evidentemente, frutto delle diverse iniziative introdotte negli anni passati, soprattutto sulla gestione del traffico e del parco veicolare che a Firenze hanno avuto un evidente effetto sull’abbassamento del biossido di azoto che registra un’inversione rispetto ad una tendenza alla stazionarietà di questo inquinante in città negli ultimi anni. La zona della piana lucchese continua invece ad essere in una situazione difficile per quanto riguarda le polveri, a causa prevalentemente della combustione delle biomasse. Nonostante gli incentivi introdotti dalla Regione Toscana per la sostituzione degli impianti di riscaldamento domestico verso tecnologie meno inquinanti, in pochi purtroppo hanno attinto a questi fondi. È evidente quindi che su questo piano ci sia ancora molto da lavorare, soprattutto in termini di sensibilizzazione ed educazione della cittadinanza».
«I miglioramenti osservati per alcuni inquinanti – ha continuato il Direttore generale – non ci devono quindi far abbassare la guardia, anche perché la sfida oggi è anche gravata dai cambiamenti climatici che mostrano i loro effetti importanti anche sulla matrice aria. Il regime delle piogge, ad esempio, non ha più una distribuzione temporale stagionale ed assistiamo sempre di più a fenomeni temporaleschi di breve durata, ad alta intensità e molto concentrati; l’assenza di piogge costanti fa venir meno il fenomeno di pulizia dell’aria, il cosiddetto rain-cleaning o rain-washing; la mancanza di questo fenomeno, combinata al riscaldamento degli strati superficiali dell’atmosfera ed all’aumento della pressione atmosferica, determinano uno schiacciamento al suolo degli inquinanti con conseguente peggioramento della qualità dell’aria che respiriamo. Come Agenzia stiamo iniziando a monitorare e studiare questi aspetti, la correlazione, cioè, tra cambiamento climatico e inquinamento atmosferico, confrontando in particolar modo i dati delle piogge e delle polveri sottili, per capire come le prime incidano sulla concentrazione delle seconde».
Il Direttore tecnico, Marcello Mossa Verre, si è soffermato su alcune sfide tecnico-scientifiche poste dalla nuova Direttiva europea della qualità dell’aria. «I limiti di concentrazione per i vari inquinanti che entreranno in vigore a partire dal 2030 – ha affermato Mossa Verre – saranno circa la metà di quelli attualmente in vigore; sarà quindi importante lavorare per capire quali possano essere le cause dell’inquinamento per cercare di contenerlo al di sotto dei livelli conseguiti finora, livelli che ormai risulta sempre più difficile abbassare. Per quanto riguarda, ad esempio, il caso della piana lucchese, la sfida per l’Agenzia dal punto di vista tecnico sarà quella di dotarsi di strumentazione che ci permetta di individuare l’origine delle polveri che si presentano con elevata concentrazione: in tal senso, Arpat si è già dotata di una strumentazione che studia e misura il black carbon, uno dei prodotti della combustione delle biomasse, e che ci consente di capire quale può essere l’origine delle polveri. La Direttiva, inoltre, pone l’accento sulle polveri ultrafini che dal punto di vista sanitario sono quelle più pericolose e che dovranno essere studiate; anche su questo versante Arpat oggi già dispone di una specifica strumentazione che serve proprio a studiare queste polveri e su cui stiamo facendo esperienze interessanti. La misura di queste polveri, ad oggi, non è però normato, se non a livello tecnico. Un ultimo aspetto interessante che la Direttiva introduce è quello relativo ai cosiddetti hotspot, i punti critici per l’inquinamento atmosferico, zone cioè in cui la situazione è particolarmente critica per l’intensità e la localizzazione di certi fenomeni di alta concentrazione di inquinanti, tipici ad esempio di certe aree urbane. Anche questo richiederà l’utilizzo di strumenti in grado di studiare i fenomeni in tempo reale».