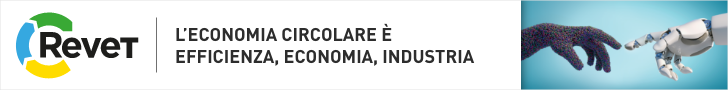Al vertice di Parigi sull’Ucraina si parla di aumentare le spese militari, ma dalla capitale francese emerge anche un’altra voce: «L’Europa resti se stessa, basi la sua influenza sul diritto e sulla giustizia economica, fiscale e climatica»

La notizia è che si sono visti. Il principale risultato è che in Borsa le azioni dell’italiana Leonardo, della francese Dassault Aviation, della tedesca Rheinmetall e delle altre aziende della difesa europee interessate da un eventuale aumento delle spese militari è schizzato a valori record. Per il resto, il vertice convocato da Emmanuel Macron a Parigi per rispondere alle mosse di Stati Uniti e Russia sull’Ucraina non ha fatto segnare sostanziali passi avanti.
Gli undici leader riuniti all’Eliseo hanno riconosciuto che siamo entrati in una stagione nuova e che, per dirla con le parole di Ursula von der Leyen, «la sicurezza dell’Europa è a un punto di svolta, si tratta dell’Ucraina ma anche di noi, abbiamo bisogno di un approccio d’urgenza, abbiamo bisogno di aumento della difesa, e abbiamo bisogno di entrambe le cose adesso». Ma nessun accordo è stato siglato, come del resto sarebbe stato impossibile, in un appuntamento informale come questo. E però è anche significativo, e non certo in senso positivo, che al tavolo siano emersi più distinguo che punti di convergenza, sia sull’aumento oltre il 2% del Pil delle spese per il settore difesa e la formula per svincolarle dalle norme contro lo sforamento del deficit e sia sull’eventuale invio di soldati europei per garantire un cessate il fuoco - favorevoli Gran Bretagna e Francia, contrari Germania, Spagna, Polonia e Italia - con tra l’altro la presidente del Consiglio Giorgia Meloni che ha plasticamente rimarcato la sua contrarietà alla formula scelta per l’incontro, arrivando solo quando tutti gli altri leader erano già nel palazzo e assumendo un’aria accigliata o neanche guardando verso l’obiettivo per le classiche foto di rito. Il motivo? per la nostra premier è un errore muoversi in ambito europeo dando l’impressione di agire contro o comunque non in sintonia con gli Stati Uniti di Trump.
Le prossime settimane diranno se a Parigi sono stati gettati i semi per un’Ue in grado di agire in modo compatto ed efficace sia in rapporto all’Ucraina sia per quel che riguarda i rapporti con gli Usa. Ma intanto è dalla stessa capitale francese che si fa sentire una voce che indica quale potrebbe essere la giusta direzione da prendere. Se da Oltreoceano Trump invoca un aumento delle spese militari per la Nato da parte dei Paesi europei fino ad arrivare al 5% del Pil, l’economista francese Thomas Piketty scrive nel suo blog pubblicato su Le Monde che l’Europa deve innanzitutto «rimanere se stessa»: «Nessuno nel continente, nemmeno la destra nazionalista, vuole tornare alle posizioni militari del passato». Invece di dedicare le sue risorse a un’escalation senza fine e «ammassando carri armati», scrive Piketty, l’Europa deve «basare la sua influenza sul diritto e sulla giustizia», lavorare su sanzioni finanziarie mirate. «Soprattutto, l’Europa deve ascoltare la domanda di giustizia economica, fiscale e climatica che viene dal Sud del mondo. Deve tornare a investire nel sociale e superare definitivamente gli Stati Uniti in termini di formazione e produttività, come ha già fatto in termini di salute e aspettativa di vita. Dopo il 1945, l’Europa si è ricostruita grazie allo Stato sociale e alla rivoluzione socialdemocratica. Questo programma non è completo: al contrario, deve essere visto come l’inizio di un modello di socialismo democratico ed ecologico che ora deve essere ripensato su scala globale».
Il docente di economia presso la École des hautes études en sciences sociales riconosce a Trump un merito: quello di chiarire le cose. Perché se c’erano ancora persone che esprimevano dubbi in proposito, ormai la situazione è ben delineata: «La destra esiste e parla forte. Come spesso in passato, prende la forma di un mix di nazionalismo brutale, di conservatorismo sociale e di liberalismo economico sfrenato. Si potrebbe qualificare il trumpismo di nazional-liberalismo, o più precisamente di nazional-capitalismo». Di fronte a questo l’Europa, che già in un precedente testo per Le Monde Piketty aveva invitato a «uscire dal letargo», deve muoversi con decisione: «L’Europa ha i mezzi per affrontarlo, a condizione di riprendere fiducia in se stessa, di stringere nuove alleanze e di analizzare serenamente i punti di forza e i limiti di questa matrice ideologica». I limiti li indica bene, l’economista francese, sia nei confronti del costo pagato dagli stessi cittadini statunitensi sia nel rapporto con un’altra potenza come la Cina. E poi c’è un altro fattore da tener presente. «La forza del capitalismo nazionale sta nel glorificare il potere e l’identità nazionale, denunciando le illusioni della retorica spensierata sull’armonia universale e l’uguaglianza di classe – scrive Piketty – La sua debolezza è che si scontra con le lotte di potere e dimentica che una prosperità sostenibile richiede un investimento educativo, sociale e ambientale che vada a beneficio di tutti».
Se von der Leyen dice che «a Parigi abbiamo ribadito che l’Ucraina merita la pace attraverso la forza», questa forza sta forse meno nel «bisogno di un aumento della difesa in Europa» invocato dalla stessa presidente della Commissione Ue e più in un lavoro sulla «debolezza» indicata da Piketty e su quel diritto e quella giustizia, sempre citati dall’economista francese, su cui è fondata l’Europa.